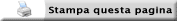|
I Rolling Stones, rampolli brillanti delle Art School inglesi che, solcando elegantemente, ma in senso vietato, lo specchio di Alice, scoprirono pianeti musicali paralleli e eretici, quelli del Blues elettrico-elettronico, forse si sono sempre strafatti di tutto e fatti più o meno tutte e tutti, con la stessa voracità imperiale di Churchill. Ma con altri effetti, sia sulla linea, che sulla pelle, che sul «british sound». La simpatia per il diavolo deve essere stata contraccambiata gentilmente anche se, «umano troppo umano», mai il quartetto si è venduto l’anima. Se non a B.B.King.
30 anni dopo The Last Waltz, elogio «funebre» della Band, di Robbie Robertson, di un infernale club, il Fillmore, e della musica che doveva cambiare il mondo, ma non pare sia riuscita, il rock è inquietantemente vivo e erotico.
Almeno a giudicare da questo rockumentary (summa del genere, nato per moltiplicare l’energia collettiva di una performance «live») che aprì la Berlinale 2008, edè diretto dal recidivo Martin Scorsese, che proprio sul set di Woodstock iniziò il mestiere.
Splende una stella (Shine a light), dal titolo di un grande successo dei Rolling, è anche un omaggio commuovente alla generazione dei documentaristi anni ’60 (e ai capostipiti del cinema verità e di Woodstock, i fratelli Maysles) che con due, dieci, cento cineprese, allora pure «mute», e il Nagra da sincronizzare, si buttavano nella mischia, tra fans scatenati, manager mafiosi e vedette più assuefatti di mescalina, Lds e alcool messi insieme.
Qui sono quasi 20 le performance complete, più gioielli di repertorio (perfino dal «maledetto» Charlie is my darling, il primo doc sulla band di Peter Whitehead), montate dallo scienziato pazzo David Tedeschi che ha utilizzato l’intrecciato lavorio di 20 cineprese in movimento, sincronizzandole come mai un solo essere umano potrebbe (anche se, ora, le cineprese registrano il suono). Quelle fissate, ai lati del palco, quella di dietro sulla gru,quelle mobili, tra il pubblico, e quelle sotto il «corridoio da sfilata di Mick» (ricordate la monumentale e anfetaminica apologia di Hal Asbhy a Jagger «atleta»?)...
Anche qui domina il pignolo, attentissimo e perfezionista Mick: al suo fianco la leading guitar, perennemente in trance, Keith Richard, con il calumet sempre acceso; il batterista Charlie Watts (il più autoironico, tuttora) e l’estatica chitarra ritmica Ronnie Wood. Quattro stelle fisse splendenti in un film già classico, che essendo diretto da quel gambler di Scorsese, che gioca al regista «operistico», prevede ogni micromossa sul palco. Il filmone è in parte finanziato dal Clinton Fund, che fa opere di bene e controinformazione (su Aids, inquinamento, etc.) ed è presentato proprio dall’ex presidente-sassofonista con al fianco il probabile futuro candidato democratico alle presidenziali. Ma il movente segreto del film è che il rock più va verso Obama e l’african-american, più si rigenera.
Shine a light è un’operagiovane e entusiasta sui quattro eterni amici inglesi, oggi travestiti da rugosi stregoni hopi. Un omaggio da fan e coetaneo, dopo una trentina di lavori che si sono interrogati sulla musica radicale, alla scoperta delle sorgenti africane del jazz, come Feel Like Going Home, o Bob Dylan, No Direction Home). Certo è duro sopravvivere alle tonnellate di sostanze che quella generazione di anime belle fu costretta a ingerire per sopravvivere psicologicamente ai veri veleni del mondo (atomica, Vietnam, Nixon, Johnson, Reagan, i Bush, centroamerica, Iraq...) e alla fatica di offrire in dono totale, quasi ogni sera, da 50 anni, al pubblico cannibale questo rock, melodicamente più hard del Liverpool style, ma meno policentrico, anzi a «centralismo democratico». Così si si è molto alterata questa musica «postumo», in mutazione continua e impercettibile. E lo spettacolo non è più solo concentrato sul finish fisico e glamour del vocalist più transessuato e trascinante della storia. Mick ecompagni disegnano sculture improprie spaziotemporali («cosa avresti fatto se non il musicista?» chiedono a Charlie Watts, tra i 20 materiali d’archivio utilizzati: «il designer»), dall’imitazione del «volo Nureyev» al «make-up cretese per gli occhi di Keith Richards, cui sono affidati due intensi e struggenti assolo da vocalist), fino alle mille smorfie espressive, dalla rabbia del kamikaze all’urlo della bimba dolce, che sono la specialità comunicativa, le «variazione Goldberg» della forma e della sostanza dell’espressione Jagger.
La rielaborazione dei successi più famosi si avvale poi, per rafforzarne la densità d’impatto, di una decina di musicisti di supporto (4 nella sezione fiati, 2 coristi, una di Brooklyn, uno di Queens, un tastierista, un basso...) e di 20 geniali direttori della fotografia, da Albert Maysles (Gimme shelter, 1970) a Ellen Kuras e Robert Ellswit (Il petroliere di P.T. Anderson). Certo questo è rock da camera, ormai, che non incendia più gli stadi e nonrichiede back stage, interviste, spezzare lance contro, filtri cromatici caleidoscopici, controluci e tutto il repertorio Mtv. Quasi galoppa a ritroso, invece, questo rock rotolante, verso le sue radici blues, l’essenzialità delle 12 corde, il «movimento da fermo» da mummia egizia, il gesto sacro del danzatore di flamenco: meno elettricità, più sciamanesimo lisergico, più Santo & Johnny e Shadows, perfino.
Il potere ha disinnescato in mezzo secolo la pericolosità sovversiva, virale e contagiante del rock? Sembrerebbe, ma fanno male oggi ad allertarsi solo i pompieri negli spazi rococò e neobabilonesi come questo tempio del liberty, il Beacon Theatre, Broadway, New York, 2800 posti, sede, nel 2006, della magica doppia performance dei Rolling Stones e dei loro ospiti d’onore: Christina Aguilera, platinata da Madonna, Buddy Guy che non fa rimpiangere Muddy Waters e Jack White dei White Stripes. Il rock non è morto è solo svenuto.de Il Manifesto
|