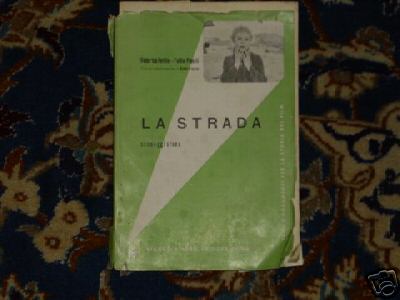|
Sembra un elfo, con gli occhi cerulei, i capelli scarmigliati e il sorriso perenne. Quasi cammina su un cuscinetto d’aria, i suoi passi così corti e felpati. Tullio Pinelli, l’uomo che abbiamo davanti, oggi centenario (è nato a Torino il 24 giugno del 1908), ha scritto, fra le altre cose, la sceneggiatura de Il bandito di Lattuada e, sempre dello stesso regista, Senza pietà. Due film a loro modo neorealisti, anche se il primo vira quasi subito in gangster story all’americana e, nonostante tutto, risulta più compiuto del secondo. In Senza pietà sembra invece più concreta la descrizione di un’Italia allo sbando nell’immediato dopoguerra dove è assente ogni speranza. Un uomo di grandi esperienze, attento osservatore di umanità variegate, spesso travolte da un destino contrario, compartecipe del dolore del mondo e della sorte degli uomini. Pinelli si inerpica sulle scale interne che portano al suo piccolo studio e si accomoda sotto una caricatura disegnata da Fellini.Riproduce l’uno, Pinelli, nelle vesti di un cacciatore, Fellini a torso nudo e tutti e due con lo sguardo rivolto all’orizzonte. È possibile dire, che la sua vita - privata e professionale - si divide tra Cesare Pavese e Federico Fellini? Beh, in un certo senso sì... non c’è alcun dubbio. Per un periodo si è dedicato alla professione forense. Che ricordi ha? Ho esercitato la professione per dieci anni e, allo stesso tempo, andavo scrivendo per il teatro e per la radio; un periodo molto bello, pieno di speranze. È stata poi la guerra a farmi abbandonare: quando sono tornato, lo studio era stato raso al suolo dai bombardamenti. Quando è approdato a Roma? Devo dire che il mio primo soggiorno a Roma fu per il servizio militare, a Castro Pretorio. Ricordo ancora quando andavamo al Foro Italico, allora in costruzione, per il foraggio e non disdegnavamo di fermarci in un’osteriaccia che era lì nei pressi. Poi tornai a Roma ufficialmente, diciamo così, per la Lux che mi mise sotto contrattoper la sceneggiatura de La figlia del capitano: è così che è iniziata la mia carriera nel cinema. Ero scettico. Ricordo ancora le polemiche con Pavese: lui asseriva che il teatro era finito e che il futuro era nel cinema. Aveva visto giusto. I suoi esordi sono proprio come commediografo... Sì, avevo scritto La pulce d’oro che vinse nel 1943 il Premio Accademia d’Italia. Ma avevo anche creato un mio teatrino di burattini; li costruivamo noi della compagnia, confezionavamo i costumi, vestiti, scarpine, tutto. In una lettera di Pavese a Sturani del 1935, si parla di una sua «sconcissima commedia», «La pulce d’oro», appunto... Beh, diciamocelo, Cesare allora era un po’ geloso... Ne «Il compagno» Pavese dice: «Combinammo in tre o quattro di andare a fare il bagno sul Lido. Poi nessuno aveva belle mutandine e andammo invece nei Castelli a far merenda...». I Castelli romani e Ostia erano tra le vostre mete preferite? Quando eravamo a Torino con Pavese facevamo grandi passeggiate in collina,per poi fermarci in qualche osteria. Pochi sanno che Pavese non amava il vino rosso perché gli ricordava il sangue e un giorno ci sfiancammo a cercare una trattoria che vendesse del bianco. La trovammo nella Piana dei Franchi dove sembrò che quel fiasco lo stesse aspettando. Il discorso del vino rosso legato al sangue gli veniva dall’aver visto il nostro amico Baraldi in una pozza di sangue, subito dopo essersi sparato. A Roma eravamo invece molto cittadini, almeno noi due. Una trattoria che frequentavamo spesso, la nostra meta preferita, era quella dei fratelli Menghi, in via Flaminia. Dall’epistolario esce fuori un uomo tutt’altro che introverso. Pavese aveva uno humor particolare che confligge con lo stereotipo tragico. Insomma, chi era Pavese? Era in effetti pieno di humor, davvero lontano dallo stereotipo in cui qualcuno ha voluto confinarlo. Certo, era un uomo di luci e ombre. Ma non dimentichiamo che uno dei suoi scritti giovanili è stato La pornoteca, testo sconcio edivertentissimo. Quale fu il reale spessore dell’infatuazione di Pavese per Milly? Milly era troppo per noi sbarbatelli. Pavese s’era incapricciato di una certa Pucci, ballerina di fila, che seguiva ogni sera dopo lo spettacolo fino in periferia, salendo sullo stesso tram e standosene in disparte. Del teatro di rivista, a parte le donne, gli piacevano molto Ripp & Bel Ami. Da studioso diceva che il loro modo di versificare era inimitabile. Buona parte della sua vita senza il compagno illustre: è stata pesante l’assenza di Pavese? La sua vicinanza contava molto. Ricordo la goduria nel frequentare insieme un cinemino in fondo a via Roma vecchia con le panche di legno e il pianoforte. Ci appassionavamo ai primi western con Tom Mix. In «Senza pietà», se non sbaglio, comincia la sua collaborazione con Fellini, co-sceneggiatore... Abbiamo cominciato prima, con Righelli, con Bonnard. Io, che ero già alla Lux gli proposi di scrivere insieme Il passatore di Coletti e lui ricambiòimbarcandomi nella scrittura del Bandito. Come vi eravate conosciuti? In modo del tutto fortuito, ad un’edicola dei giornali, in piazza Barberini. Com’era il suo rapporto con Fellini? Direi magico. Continuava al di là del lavoro e posso dire che ci compensavamo: io con l’aplomb torinese, lui con il suo essere estroverso, tipico delle sue parti. Era di una simpatia unica, allegro, curiosissimo, divertito e divertente. Anche la collaborazione con Pietro Germi è stata intensa. Ha scritto per lui, sempre insieme a Fellini, «Il cammino della speranza», Orso d’argento a Berlino e «In nome della legge» dove compariva anche Monicelli come co-sceneggiatore... Che tipo era Germi? Era ombroso, capace di incazzature violente non sempre giustificate. Ma essenzialmente un uomo buono, umile. Alla fine ritroverà Monicelli, per il quale scriverà «Amici miei» e «Il marchese del Grillo». Che rapporti ha intessuto con lui? Monicelli era molto ironico, sardonico direi, ma un po’ defilato. Tra noi non c’eramolta comunicativa, non ci siamo mai frequentati fuori dal lavoro. E Flaiano? Flaiano era un tipo straordinario, intelligentissimo. Bastava starlo a sentire. Raramente parlava della figlia (aveva un grave handicap, ndr), e di malavoglia. E allora gli si inumidivano gli occhi. È possibile che il suo spirito, per contrasto, scaturisca proprio da questo dramma. Ricordo bene la sua propensione per le avventure femminili. Quando veniva in casa mia, rimaneva incantato dai miei libri. Poi ci mettevamo a lavorare, ma ci perdevamo spesso perché lui cominciava a raccontare storie bellissime che non c’entravano nulla però col lavoro che dovevamo buttare giù. In un’intervista rilasciata Giovanni Grazzini, Fellini ricorda le scorribande notturne in auto... Di quel periodo ricordo soprattutto quando con Federico andavamo a Fregene in casa di Flaiano. In quelle occasioni, Ennio si divertiva come un bambino. Quando eravamo in acqua, gli piaceva riempirci di schizzi e, una volta rientrati, si divertivaa usare contro di noi la pompa dell’acqua, regalandoci un altro bagno. Direi che era molto contento di essere contento. È stata importante anche la collaborazione con Rossellini. Era un uomo simpaticissimo e spregiudicato, non quell’intellettuale descritto da molti ma, al contrario, un uomo sanguigno. Europa 51, che io sceneggiai, non ebbe un gran successo, che ottenne invece L’amore con la Magnani. E della Magnani che si può dire? Era debordante, a volte le sue uscite erano imbarazzanti. Bisognava accettarla com’era. Che cos’è per lei il cinema? Il cinema è arte. Quando vedo un film di Chaplin, sto assistendo a un’opera d’arte. Ha mai pensato di passare dietro alla macchina da presa? No, per carità! Bisogna avere uno stomaco così. Devi litigare con i produttori, con gli attori, con i distributori. Non era per me. Io, ad esempio, non sono mai andato sul set di un film. Quando a Fellini commissionarono Lo sceicco bianco, mi propose di girarlo a quattro mani e io rifiutai. Oggi compie100 anni... Un consuntivo? Rimpianti non ne ho; avrei magari voluto scrivere cose che rimanessero ai posteri. Le mie opere drammaturgiche passeranno, quelle di Pirandello no. Lei ha attraversato il secolo scorso, vivendo esperienze memorabili e incontrando persone che hanno fatto la storia del cinema e della letteratura. Qual è la persona o l’episodio che più le tornano in mente? Federico... (gli occhi di Pinelli si inumidiscono, ndr) mentre l’episodio che vive sempre con me è quello della Resistenza. Ricordo ancora quando, nei pressi di Alpignano, feci prigionieri quaranta fascisti della Monterosa, fiancheggiatori di Salò e ricordo pure come mi battei per salvarli dalla fucilazione. Ci mancò poco che i miei compagni partigiani mettessero me al muro!de Il Manifesto
|