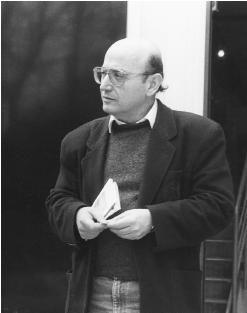|
Si è riacceso, negli ultimi tempi, l’interesse per i paesi del Mediterraneo e si è discusso a Parigi della loro eventuale unione.
Intanto, è sempre meno menzionata la Grecia, matrice primaria della civiltà europea. E scarsa attenzione viene dedicata ai fermenti culturali e artistici in atto in quella peninsola e ancora meno al suo cinema.
Infatti, dopo un breve periodo di entusiasmo per certi suoi registi, una ventina d’anni fa, e, in particolare, per uomini quali Cacoyannis, Papatakis e Anghelopulos, è calato sul di essi un assordante silenzio.
Raramente sono citati i grandi attori greci ( da K.Paxinou a Irene Papas, a Melina Mercouri) che pur hanno contribuito alla realizzazione di capolavori anche stranieri. (Si pensi, per la Paxinou alla "mater dolorosa" di "Rocco e i suoi fratelli"). Risulterà, perciò, utile scorciare un rapido ritratto di un autore quale Theo Anghelopulos notevolmente trascurato dalla pubblicistica italiana. (Difficile reperire monografie a suo riguardo).
Nato ad Atene nel 1936, dopo la laurea in lettere, studia all’IDHEC di Parigi, diplomandosi con un cortometraggio, "L’émission" nel 1966, molto lodato dalla critica francese. Tornato in patria lavora qualche tempo come recensore cinematografico del quotidiano "Allaghi" di Atene, passando poi all’attività registica nel 1970. È l’anno del suo esordio con: "Ricostruzione di un delitto" in cui l’intreccio poliziesco è ben fuso con l’indagine sulla società greca di quelli anni.
L’opera gli varrà il "Premio Salonicco" per il coraggio mostrato nel non accodarsi all’andante produzione in voga.
I tre film successivi si riveleranno una sorta di trilogia anticonformista sulla storia del suo paese.
La prima "I giorni del ’36" (1972) narra le vicende politiche del dittatore Metaxas: è una ampia panoramica sulla involuzione della borghesia in quei tempi oscuri.
Lo stile risente della lezione di Brecht con effetti di "straniamento" attuati grazie a stacchi improvvisi e spiazzamenti concettuali nel discorso, già complicato di per sé.
Di maggior lena (e lunghezza) si rivelerà "La recita" (1975) in cui si rappresenta il girovagare di un gruppo di commedianti durante il secondo conflitto mondiale. In essa vengono inseriti molteplici richiami ai miti classici (gli Atridi) e risuonano note epiche in chiave con la temperie degli anni tra il 1940 e il 1958.
È il film che apporterà al regista fama internazionale e pressoché unanimi elogi.
Minor successo arriderà a "I cacciatori" (1976) che riflette lo stesso periodo ma risulta sovraccarico di intenzioni didattiche e di frantumazioni del racconto per immagini.
Nel 1980, in "Alessandro il grande" ("Megalexandros") Anghelopulos dipinge i casi di un fuorilegge che ha assunto il nome dell’antico condottiero macedone.
L’interprete è Omero Antonutti che si immedesima con slancio nel ruolo e rende il personaggio del tutto convincente, nei gesti e nella psicologia.
Così, si ha la riconferma di una rigorosa coerenza nell’impostare temi avventurosi senza digressioni spettacolari e con energico impegno.
Significativi sono i piani-sequenza con i quali si esplorano sia i selvaggi "santuari" di montagna sia gli interni claustrofobici, in cui, di volta in volta, si rifugia l’arrogante bandito.
E il "Leone d’oro" ottenuto a Venezia sarà la laurea "cum laude" per l’autore greco, impostosi di autorità alla giuria.
Nel 1984, egli realizza "Viaggio a Citera" in cui si presentano i casi drammatici di un rivoltoso seguace del comunista Markos, rientrato dopo molti anni dall’esilio in URSS. Il filo rosso sotteso è quell’interrogarsi sul fenomeno del tempo che disgrega gli ideali e innesca dolorose delusioni.
Due anni dopo, ne "Il volo" (int.Marcello Mastroianni) c’è la parabola dell’apicultore cui viene a mancare la fiducia del suo lavoro (e di conseguenza, nella vita stessa).
Infatti, egli finisce col darsi la morte per mezzo delle sue amate bestioline.
Vi si avverte spesso la mano del poeta Tonino Guerra, collaboratore alla sceneggiatura. Lodevole è la cura delle inquadrature mai fini a se stesse (una lezione implicita ai tanti registi d’oggi, anche se abili ma purtroppo sciatti e talvolta sgrammaticati).
Nel 1988, nel film "Paesaggio nella nebbia" si snoda il lungo viaggio dei due fratellini alla ricerca del padre che la madre ha ritenuto emigrato in Germania. Nel percorso un pò troppo avventuroso c’è qualcosa di costruito ad hoc e ciò provoca qualche incredulità nello spettatore.
Resta, di positivo, l’invito all’uso della ragione e della sopportazione come antidoti alla disperazione e agli inutili rancori.
Tre anni dopo, ne "Il passo sospeso della cicogna" (1991) si ritrova immutato l’impegno umano e stilistico dell’autore.
La vicenda è quella di un regista TV che crede di aver inquadrato tra la folla il volto di un parlamentare scomparso misteriosamente da anni.
Di rilievo particolare sono le riprese dei movimenti dei profughi tra Albania e Grecia, con campi lunghi e lunghissimi che rimandano a certe splendide sequenze di S.M.Eisenstein, quasi in risarcimento a certe riserve che oggi si avanzano, in modo insipiente (o ridicolo) sulle opere del grande regista russo. Nel 1995, il regista greco guadagnerà a Cannes "Il Gran Premio Della Giuria" con "Lo sguardo di Ulisse". Di nuovo, il protagonista è un cineasta che va alla ricerca della bobina di un vecchio documentario (H.Keitel in questa parte, sostituisce G.M.Volontè, purtroppo deceduto all’inizio delle riprese).
Uno splendido brano è l’incontro col vecchioa rchivista (E.Josephson) in quel di Sarajevo mentre vi si prepara l’ennesima tragedia per la collettività bosniaca.
Con "L’eternità e un giorno" del 1998 Anghelopulos riprende il tema del viaggio che qui èquello intrapreso da uno scrittore verso Salonicco per farsi ricoverare in una clinica dove spera in un’operazione salvifica.
La solitudine angosciosa in cui l’uomo è immerso è punteggiata dai ricordi della moglie morta precocemente, e un pò di sollievo ricaverà dall’incontro col lavavetri, un ragazzo albanese che lavora in nero per sopravvivere.
Nel ruolo principale Bruno Ganz è sempre a grande altezza nel gioco fisionomico ed assai eloquente pur nel mutismo che lo assale di frequente. E l’aura di malinconia profonda (forse preletale) è resa con tocchi lievissimi. Così, più che meritato apparirà il "Palmarès" conferito all’opera dalla giuria di Cannes di quell’anno.
Passeranno ben sei anni, però, prima che arrivi nelle sale (dalle ridotte platee) "La sorgente del fiume" (2005).
La macchina da presa segue le peripezie di un gruppo di greci rientrato in patria dall’URSS in conseguenza dello stabilizzarsi del regime sovietico. E la saga procede fino al secondo conflitto mondiale e alla guerra civile di Markos.
Il clou della storia è l’inondazione del villaggio in cui sono sistemati i profughi. Le sequenze ad essa relative sono di estrema suggestione figurativa, e l’acqua assume una valenza simbolica polimorfa come se fosse l’elemento eracliteo da cui è sorto l’uomo e che in esso potrà scomparire.
Operati con misura risultano i trapassi dal piano epico a quello lirico e viceversa.
E nonostante alcune prolissità e certi "impervi passaggi temporali" (M.Morandini) la prosa iconica di Anghelopulos non perde il suo fascinoso smalto.
Ad esempio, il primo piano del vecchio saggio dall’incrollabile fede nell’umanità ha la forza e lo spessore di un bassorilievo classico.
Insomma, nel non troppo ricco panorama del recente cinema europeo, il regista greco è stato un valido testimone delle capacità artistica di un antico popolo del Mediterraneo. Perché ha saputo ridare voce ed immagine ad una civiltà che per molti secoli ha impregnato di sè quelle poi sviluppatesi nella intera Europa.
Quale nazione di questo vecchio continente potrebbe, infatti, negare di essersi nutrita di quanto creato in Grecia da Omero o da Eschilo, e da Pindaro fino a K.Kavafis?
|