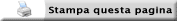|
Nella giornata del film che tutti, fuori e dentro facebook, stavano aspettando- un inchino a Fincher, maestoso con The social network - e in cui il Boss Bruce Springsteen si è mostrato al Festival dimostrando che ormai Extra ha anche i migliori assi da tappeto rosso, è utile guardare anche oltre. Al film di Claudio Cupellini, terzo italiano in un concorso abbastanza deludente, infatti, si è affiancato l’atteso è già applaudito, fuori dai nostri confini, Rabbit Hole, opera che potrebbe persino valere l’Oscar per Nicole Kidman. Due storie diverse, con al centro famiglia e assenze insopportabili all’interno di essa, due modi e metodi diversissimi di racconto. Da una parte il regista italiano si prende Toni Servillo e gli costruisce attorno Una vita tranquilla. Qui il nostro è un barbuto emigrante italiano in Germania, con una pensione-ristorante che prende il suo nome (se lo è davvero, da Rosario, lo scopriremo durante l’opera) e una moglie tedescaintelligente e innamorata. In verità ha un passato inconfessabile, che si rivela con l’epifania di una coppia di ragazzi napoletani. Proprio nell’avamposto dello smaltimento rifiuti in Germania, proprio laddove il business della monnezza potrebbe saltare e mettere piedi all’aria la camorra. Si sente puzza di criminalità (non troppo, qui almeno) organizzata e ramificata in tutta Europa, ma Servillo qui più che al Titta di Le conseguenze dell’amore assomiglia più al commissario de La ragazza del lago. Cupellini gli chiede una recitazione sotto le righe, a lui servono pochi sguardi per disegnare una vita passata e negata e un’altra presente e in pericolo. Un film molto lineare, anche ripetitivo, che per un’oretta va giù liscio, senza troppi rischi. Poi, quando sopraggiunge la complessità, la risoluzione dei nodi di sceneggiatura, il film crolla miseramente. Pur avendo pochi bivi, il lungometraggio prende la direzione sbagliata, risulta poco credibile nelle sue scelte: in quella coppia digiovani italiani più o meno rissosi che imperversano nel piccolo paesotto tedesco senza ostacoli, nel bambino lasciato e ripreso all’autogrill, in un ospite che sparisce senza che nessuno si chieda come e perché. Ovvietà che demoliscono il lavoro discreto fatto fino a quel momento, che cozza col resto del film come la ricetta principe del cuoco protagonista, cinghiale e granchi, e che lasciano il dubbio che ormai Servillo sia un cavallo di razza troppo buono perché possa essere cavalcato da qualsiasi fantino. E che i registi si siedano sul suo talento e così tutti gli altri: perché anche se la luce è sbagliata, lui sa come valorizzarla, anche se la scrittura è mediocre, lui sa come nasconderla.
Non fa quest’errore John Cameron Mitchell, che dopo Hedwig e lo "scandaloso" Shortbus (ricordate l’inno americ-anale?), ci stupisce con Rabbit Hole. Che sembra un Amabili resti sottotono, apparentemente, e che invece è come la brace sotto la cenere: arde ostinato, disperato, in quel turbinioarrabbiato di emozioni e dolore che dà la perdita ingiusta di un figlio. Nicole Kidman e Aaron Eckhart sono una coppia che ha visto il suo sogno di felicità, il biondissimo Danny, ucciso da un’auto. Un adolescente alla guida. Una ferita immensa e insopportabile, che pesa su tutti, come la colpa che solo Eckhart, padre piegato ma non spezzato (e qui sembra il Bill Irwin di Rachel sta per sposarsi di Demme, ma più giovane), sembra poter sostenere per tutti. Canne e chiacchierate "sbagliate", sfoghi inconsulti e schiaffi, morali e non, per un’ora e mezza anneghiamo nel dolore più atroce, infame, insuperabile: sopravvivere a un figlio. Mitchell ce lo disegna sulle facce di interpreti bravissimi- peccato per il botulino della Kidman, anche se è così brava da non farcelo notare troppo- e in dettagli delicati e allo stesso tempo feroci. Due modi diversi di raccontare rabbia e dolore, seconde possibilità e rinascite. Molto diverse, e l’impressione è che la colpa non sia tutta nei budget e neidivi. Forse dobbiamo imparare a raccontare certe storie senza paura.
|