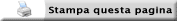|
Racconta Fania Pascal che un giorno, mentre si trovava in ospedale dopo esser stata operata alle tonsille, ricevette una visita di Ludwig Wittgenstein, che s'informò sulla sua salute. «Gracchiai: "Mi sento come un cane che è stato investito da una macchina". Lui ne fu disgustato: "Tu non sai come si sente un cane che è stato investito"». Si può vedere in questa risposta scostante un'ennesima riprova di quel carattere insopportabilmente altero che i contemporanei attribuiscono al filosofo, «forse il più perfetto esempio che io abbia mai conosciuto di genio così come è tradizionalmente inteso, ardente, profondo, appassionato e dominante», come di lui scrisse Bertrand Russell. Ma si può vedere la cosa anche in modo differente. Diamo per scontato che Wittgenstein avesse ragione, che cioè effettivamente la sua amica non avesse idea di come si sente un cane che è stato investito da una macchina (sebbene potesse lecitamente presumere che un cane arrotato non si senta affattobene). Cos'è che, agli occhi di Wittgenstein, fa realmente problema nella sua affermazione, al punto da darle quella risposta? Semplicemente, ma non banalmente, il fatto che si tratta di un'affermazione che non ha alcun legame con la verità; più precisamente, che non si propone di descrivere la realtà. In quel momento, Fania non pensa a come davvero può sentirsi un cane che è stato investito, né intende istituire una qualche analogia fra il suo stato psicofisico e quello del malcapitato quadrupede. La descrizione delle sue sensazioni è dunque qualcosa che sta inventando di sana pianta o che riprende da un luogo comune, senza porsi il problema di fornire un'accurata rappresentazione della realtà e, quindi, di sottomettersi alle costrizioni che un impegno del genere inevitabilmente richiede. Agli occhi di Wittgenstein, la sua colpa è, conseguentemente, massima: non solo non ha detto come stanno davvero le cose, ma non ci ha nemmeno provato.
Parole in assenza di verità
«È proprioquesta assenza di un legame con un interesse per la verità - questa indifferenza per come stanno davvero le cose - che ritengo essenziale per la definizione di stronzate», scrive commentando l'episodio Harry G. Frankfurt, eminente filosofo morale di Princeton, in un serissimo libretto volto ad introdurre ad «una conoscenza teoretica delle stronzate», che negli Stati Uniti di George W. Bush è diventato un bestseller. Uno che dice stronzate, infatti, non è propriamente un bugiardo, perché il bugiardo, proprio nella misura in cui si propone di nasconderci qualcosa, presume che esistano dei fatti in qualche modo determinati e conoscibili (la bugia presuppone la verità). Chi racconta stronzate, invece, non rifiuta l'autorità della verità, ma semplicemente non si preoccupa che le cose che dice descrivano correttamente la realtà: «le sceglie, o le inventa, perché si adattino ai suoi scopi», ed è per questo che - osserva a ragione Frankfurt - «le stronzate sono un nemico della verità piùpericoloso delle menzogne».
È evidente, però, che la critica implicita nella risposta di Wittgenstein a Fania Pascal regge solo se si postula che ci sia davvero una differenza tra il vero e il falso, tra la realtà e l'immaginazione. Se così non fosse, infatti, avremmo davanti a noi solo due strade: tacere ovvero - prosegue Frankfurt - «continuare a produrre asserzioni che danno a intendere di descrivere le cose come stanno, ma che non possono essere altro che stronzate».
Non è dunque un caso che il filosofo americano rinvenga la matrice della «contemporanea proliferazione delle stronzate» in quel diffuso scetticismo proprio del sentire postmoderno, secondo il quale «noi non abbiamo alcun accesso affidabile a una realtà oggettiva, e pertanto non possiamo conoscere la vera realtà delle cose»: sono proprio simili idee «antirealistiche», dice Frankfurt, ad aver determinato «l'abbandono della disciplina richiesta dall'ideale dell'esattezza e l'adozione di una disciplina di genere deltutto diverso, imposta dal perseguimento dell'ideale alternativo della sincerità» (come dire: se sei in buona fede, puoi dire qualunque stronzata, tanto io non posso che fare altrettanto o tacere). Ma per quanto egli abbia buon gioco nell'argomentare che, «come esseri coscienti, esistiamo solo nella nostra reazione alle cose», onde non è possibile pensare di poter fare qualunque asserzione di verità su noi stessi e al contempo negare che si possa farla sulle cose stesse, il problema resta: dopo il principio di indeterminazione di Heisenberg, la teoria della relatività di Einstein e il teorema d'incompletezza di Gödel, che sembrano dirci che «l'uomo è la misura di tutte le cose» perfino quando abbiamo a che fare con sistemi rigorosamente precisi come la fisica teorica e la matematica, che diritto abbiamo di parlare di «realtà» e di «verità»? Non ne viene piuttosto la conferma che il concetto di «oggettivamente vero» è un mito socialmente costruito per legittimare l'influenza delleclassi dominanti? Ovvero che l'epistemologia non è altro che una sociologia del potere?
I paradossi di Gödel
Jean Cocteau scrisse nel 1926 che «la peggior tragedia di un poeta è quella di essere ammirato attraverso l'essere frainteso». In effetti, benché i guru del postmoderno abbiano arruolato sia Einstein che Gödel fra i pionieri della grande rivolta contro l'oggettività e la razionalità che ha caratterizzato buona parte del secolo appena concluso, entrambi - come giustamente ci ricorda la filosofa statunitense Rebecca Goldstein - erano «convinti sostenitori dell'oggettività, e interpretavano i loro lavori più famosi come supporto a favore di questa posizione sempre più impopolare».
In effetti la teoria della relatività non ha nulla a che fare con l'adagio «tutto è relativo» a cui spesso la si riduce, ma si propone di mostrare ciò che non cambia nelle diverse misurazioni che di un evento si possono effettuare in relazione a differenti sistemi di riferimento e, con ciò, dirappresentare la natura oggettiva dello spazio-tempo, così differente dalla nostra umana e soggettiva percezione dello spazio e del tempo. E ancor più spesso dimentichiamo che anche Gödel si interessava alla possibilità di protendersi oltre le nostre esperienze, per descrivere quel mondo «là fuori» che l'amico Einstein aveva detto esistere «indipendentemente da noi esseri umani [...] come un grande, eterno enigma, solo in parte accessibile alla nostra indagine e al nostro pensiero». Il fatto poi che, essendo Gödel un matematico, quel mondo «là fuori» non fosse altro che l'oggettività della matematica, non cambia nulla nel suo rifiuto radicale dell'idea che l'uomo potesse essere «la misura di tutte le cose»: al contrario, rendeva assai più ferreo quel razionalismo che condivideva con Einstein, visto che non solo acconsentiva con lui nel ritenere che «Dio non gioca ai dadi», come invece suggerisce la meccanica quantistica, ma addirittura riteneva che nulla di ciò che accade nel mondofosse dovuto al caso o alla stupidità. (Fu questo «assioma interessante», come lo definì Ernst Gabor Strauss, a fargli dichiarare di essere un «antievoluzionista», cioè a fargli escludere che l'evoluzione potesse essere «spiegata» tramite il ricorso al caso e alla contingenza; «neppure Stalin credeva nell'evoluzione - disse una volta al filosofo Thomas Nagel - e lui era un uomo molto intelligente»).
Insomma, ad Einstein e a Gödel non piacevano le stronzate e almeno in una circostanza - si discuteva se ammettere un sociologo all'Institute of Advanced Study di Princeton - Gödel distinse accuratamente «l'influenza che le idee possono avere dalla loro verità oggettiva». Del resto, l'idea che la verità non esista è intrinsecamente paradossale, così come il famoso detto del cretese Epimenide secondo cui «tutti i cretesi sono bugiardi»: se fosse vera, sarebbe al tempo stesso falsa, poiché enuncerebbe una verità nel momento stesso in cui nega che ciò sia possibile; se fosse falsa,specularmente, sarebbe vera, perché si risolverebbe nell'affermazione che la verità esiste.Di solito, un'affermazione che sia al tempo stesso contraddittoria e dimostrabile produce una catastrofe della ragione (basti pensare a certi marxisti che ancora si aggirano, dopo cento e passa anni, nel labirinto del valore-lavoro). Il genio di Gödel, che poi è ciò che gli consentì di evitare la facile scorciatoia di mettersi a dire stronzate, consistette nel lavorare sulla struttura concettuale della paradossalità (sulla indecidibilità), riuscendo a trasformare una catastrofe della ragione nella dimostrazione che c'è sempre qualcosa in agguato «là fuori», ossia che al di là del punto in cui siamo pervenuti ci può essere un controesempio capace di farci trascendere lo stesso sistema che abbiamo costruito: qualcosa di cui magari non siamo ancora capaci di parlare ma di cui, certamente, non possiamo tacere (e anche Wittgenstein, grazie al marxista Sraffa, avrebbe finito col convincersene).
Iparadossi di Gödel
Questo «qualcosa là fuori» è, al contrario, ciò che costituiva la bestia nera del formalismo, vero padre naturale di quel sentire postmoderno così giustamente inviso a Frankfurt e a quanti come lui non sopportano le stronzate: era stato il formalismo, infatti, a cercare di «purificare» il sistema assiomatico della matematica da ogni ricorso all'intuizione, con la scusa che non si poteva mai sapere quali intuizioni fossero «autentiche» e quali no (ma in realtà allo scopo di evitare che l'eventuale scoperta della falsità degli assiomi potesse far crollare tutto il sistema). Il fatto che Gödel abbia invece dimostrato che in ogni sistema formale si possono formulare proposizioni indecidibili (cioè non dimostrabili e la cui negazione non è dimostrabile) e che, di conseguenza, la «coerenza» di un sistema formale non può essere dimostrata entro il sistema stesso, permette di ipotizzare che perfino nella nostra «società dello spettacolo» possa essere pronunciata unabattuta a doppio senso come la chiusa dei Pagliacci di Leoncavallo: «la commedia è finita!». E una battuta del genere, formulata secondo le regole del sistema ma capace al tempo stesso di trascenderlo (proprio come Il Capitale di Marx), confermerebbe che non è il «realismo ontologico» a dover essere chiamato in causa per spiegare l'odierna recrudescenza reazionaria e autoritaria, ma l'idealismo sotteso ad ogni abbandono della ricerca dell'oggettività. Che poi è ciò che ha lucidamente argomentato tempo addietro Maurizio Ferraris su queste stesse pagine e sa chiunque si sia scontrato con la volontà di potenza che immancabilmente si cela dietro ogni «pensiero debole».
Quasi cent'anni fa, Lenin osservò che il crollo della vecchia fisica, dovuto alle grandi scoperte scientifiche di allora, aveva indotto taluni scienziati a scivolare, «per ignoranza della dialettica, nell'idealismo attraverso la strada del relativismo»: invece di insistere «sul carattere approssimativo, relativo di ogniteoria scientifica sulla struttura della materia e le sue proprietà», essi avevano finito col «negare l'oggetto indipendente della nostra conoscenza, l'oggetto che la conoscenza riflette in modo approssimativamente esatto, relativamente giusto» (quando ci riesce).
Immagini del mondo
Potrà sembrare una stronzata richiamare le sue considerazioni di questi tempi, ma se c'è un aspetto interessante del programma di ricerca associato alle neuroscienze e alle scienze cognitive è la ripresa di una concezione materialistica della realtà, in cui i «dati di coscienza» vengono scalzati dal rango di unici oggetti conoscibili per acquisire il più modesto - benché essenziale - ruolo di strumenti volti ad afferrare qualcosa di indipendente da noi. «Ogni conoscenza - ha scritto in quest'ottica Giulio Tononi - è pertanto adattamento della struttura del cervello nonché del corpo alla complessità del mondo».
Questa «plasticità» delle nostre strutture cerebrali - affatto ignota fino a quarant'annifa, quando si riteneva che la conformazione della corteccia cerebrale dipendesse essenzialmente dai geni e che l'ambiente non esercitasse alcuna influenza sui neuroni e i circuiti cerebrali - è ciò che, volendo, ci può consentire di «costruire» immagini (descrizioni) più accurate della realtà con la quale interagiamo, per comprenderla e - putacaso - perfino trasformarla. Non è certo un compito facile, anzi: si tratta di accogliere su di sé il peso dello sforzo inevitabilmente connesso ad ogni pensiero «uncommon», che implica una severità concettuale che talora può sfociare perfino in un senso di frustrazione (specie di fronte al successo di «agitatori» che si rendono stupidi quanto i loro seguaci, in modo da far credere a questi ultimi di essere intelligenti come loro). Ma è un compito necessario, se davvero vogliamo evitare l'impoverimento materiale e morale cui ci ha condannato una generazione incapace di risolvere i problemi che pure ha avuto il merito di porre.
È certo che - perdirla ancora con Frankfurt - «una persona che sceglie di cavarsela a forza di stronzate ha molta più libertà. La sua prospettiva è panoramica, invece che particolare», e un approccio del genere è ciò che oggi consente a molti di parlare senza sapere nulla o quasi di ciò di cui parlano (nel qual caso, ovviamente, «le stronzate sono inevitabili»). Ma se è vero che la «libertà dei postmoderni» si risolve, au fond, nella libertà di dire stronzate, potrebbe darsi che siamo alle soglie del parto di un nuovo materialismo, un parto in cui «l'essere vivo e vitale è inevitabilmente accompagnato da qualche prodotto morto: scorie destinate all'immondezzaio», chiosava Lenin. Oso sperare che le molteplici forme dell'idealismo contemporaneo, col loro codazzo di mercati autoregolantisi, dionisiache moltitudini e decrescite conviviali, possano essere presto considerate alla stregua di queste scorie. Stronzate, appunto.da Il Manifesto
|