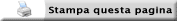|
Di Seyla Benhabib l’editore Cortina ha appena mandato in libreria in Italia l’\>ultimo libro, I diritti degli altri: un lavoro sulla comunità politica e sui principi e le pratiche che regolano l’integrazione di stranieri, migranti, rifugiati e richiedenti asilo nelle nostre democrazie. La frase in esergo al volume - No human is illegal, slogan della marcia degli immigrati per i diritti civili che si tenne il 4 ottobre 2003 a New York - rende da sola le intenzioni dell’autrice. Che spiega: «Al centro della mia tesi c’è la nozione di appartenenza politica, intesa come iscrizione volontaria a una comunità politica, e la sua ridefinizione nel mondo globale. Lo stato moderno ha formalizzato l’appartenenza sulla base della cittadinanza nazionale. Ma con la globalizzazione la sovranità statale e la cittadinanza nazionale entrano tutt’e due in crisi; mentre con le migrazioni emergono nuove modalità di appartenenza, che stentano a trovare adeguataformalizzazione. La teoria politica si sforza di ridefinire una sovranità post-statuale nell’era post-westfaliana, ma non può riuscirci senza mettere in discussione la pretesa degli stati di mantenere il controllo e la protezione dei confini nazionali da stranieri, intrusi, rifugiati, richiedenti asilo. Una giusta appartenenza a mio avviso deve comprendere il riconoscimento del diritto morale al primo ingresso dei rifugiati e dei richiedenti asilo, un regime di confini porosi per i migranti, la titolarità per ogni essere umano di alcuni diritti fondamentali inalienabili: chi si trova nella condizione di "straniero" non può essere privato di questi diritti fondamentali, e a determinate condizioni acquisisce altresì il diritto civile alla cittadinanza».
Ci si potrebbe fermare a parlare più a lungo di quest’ultimo lavoro di Benhabib se il nostro incontro, avvenuto a ridosso del Festival di Filosofia di Roma della settimana scorsa, non fosse pressato da altre domande. Seyla Benhabib èanche una teorica femminista, nota in questo campo soprattutto per il suo Situating the Self (Polity Press, 1992); e in un altro dei suoi testi tradotti in italiano, La rivendicazione dell’identità culturale: eguaglianza e diversità nell’era globale (Il Mulino, 2005) sottolinea che la questione delle differenze e dei conflitti culturali non è separabile da quella della posizione che all’interno di ogni cultura e negli scambi interculturali occupano gli uomini e le donne. La tavola rotonda del Festival sull’«Universalismo della differenza», alla quale abbiamo partecipato tutt’e due con Luisa Muraro, Lidia Ravera e Francesca Brezzi, ha messo in scena alcune discrepanze e alcune difficoltà di traduzione fra il lessico politico del femminismo italiano e quello del femminismo americano, difficoltà che ruotano sull’uso diverso delle categorie di differenza sessuale e di gender e su altre diversità di percorso e di contesto. Ci era rimasta la curiosità di discuterne ancora.
Cheimpressioni hai tratto da questo breve scambio con alcune voci del femminismo italiano?
E’ stato troppo breve purtroppo, bisognerebbe istruirne uno più approfondito. Mi è parso che ci sia qui in Italia un dibattito sulla differenza sessuale molto ricco, ma difficile da tradurre nel contesto americano. Il dibattito femminista americano degli ultimi vent’anni è stato interamente occupato dalla polemica costruttivismo versus essenzialismo, declinata come gender versus differenza sessuale. Una polemica per molti versi semplicistica e piena di luoghi comuni, che ha impedito fra l’altro uno sviluppo in positivo del linguaggio della differenza e dei primi lavori di Luce Irigaray.
E’ quello che Rosi Braidotti chiama la «disconnessione transatlantica» della teoria femminista. Luisa Muraro, nella sua «lezione magistrale» al Festival, ne ha dato una sua spiegazione, attribuendo l’abbandono del linguaggio e della pratica della differenza sessuale nel femminismo americanoper un verso, sul fronte sociale, all’accanimento sulla rivendicazione del potere in competizione con gli uomini, per l’altro verso, sul fronte accademico, alla subalternità della ricerca teorica al post-strutturalismo. Che ne pensi?
Direi che sono abbastanza d’accordo, con qualche aggiunta. La polemica antiessenzialistica all’inizio faceva perno sulle tesi di Foucault e sui primi lavori di Judith Butler: il nocciolo stava nell’affermazione che qualsiasi soggettività è costruita dentro le pratiche disciplinari e che dunque non è pensabile un’essenza dell’essere umano o del soggetto che preesista a queste pratiche o ne prescinda. Affermazione giusta - e peraltro non inedita: già Marx diceva che siamo nient’altro che esseri sociali -, che col tempo è diventata però una specie di pass-partout contro un nemico di comodo, largamente inventato e fantasmatico. Quali sarebbero le posizioni essenzialiste contro cui si rivolge? A metà anni novanta, perfino il mio lavoro sul sésituato è stato tacciato di essenzialismo, per non dire quello di Carol Gilligan...
... che invece, a ben guardare, non lo è: ho avuto modo di discuterne con lei (il manifesto 25 settembre 2005). Ma quali sono i referenti sociali di questa polemica? O si tratta di un conflitto puramente accademico?
La polemica contro l’essenzialismo si è intrecciata con la degenerazione della politica dell’identità in quella che io chiamo «etica del sospetto» generalizzata. All’inizio, anche qui, si trattava delle più che legittime rivendicazioni delle minoranze etniche e sessuali contro le pratiche di esclusione e gerarchizzazione che inficiano l’universalismo: le donne di colore e le omosessuali avevano di che «sospettare» contro «la Donna» bianca e eterosessuale. Ma via via questa critica si è infilata in due vicoli ciechi: per un verso la rivendicazione di quote e pari opportunità, dentro un quadro di risorse sempre più scarse. Per l’altro verso, una politica dell’identitàsempre più individualistica, che scivola dall’appartenenza a una minoranza sessuale a un «my belonging» che nega in radice ogni possibilità di rappresentazione collettiva: nessuna può parlare per nessun’altra e alla fine ognuna parla solo a nome di se stessa. Questa deriva è del tutto in contrasto con la mia visione dell’inter-esse e di una politica basata sull’in-between, alla Hannah Arendt. Vengo dal ’68, sono una socialista democratica, eterosessuale e madre, mi è difficile riconoscermi in una politica dell’identità sessuale incapace di trovare degli interessi comuni e di fare coalizione.
C’è dell’altro, secondo me. Questa politica dell’identità frammentata, che solitamente si definisce politica delle differenze, finisce con il riprodurre il fantasma contro cui si batte, «essenzializzando» le microidentità (o differenze che dir si voglia). Mi pare più antiessenzialista una concezione della differenza come differimento dall’identità - dell’altro, del genere, della stessasingolarità - qual è quella che cerchiamo di far operare nel pensiero della differenza italiano, in questo non dissimile da alcune gender theories. Insomma, io penso che la mappa transatlantica andrebbe aggiornata e ridisegnata, decostruendo e confrontando le parole che abbiamo usato fin qui: genere, differenza, differenze, identità, singolarità...
Penso anch’io che bisognerebbe promuovere un confronto più dettagliato. Insieme a un aggiornamento dell’analisi sociale. Negli Stati uniti, l’economia post-fordista ha radicalmente trasformato i rapporti sociali fra uomini e donne, inserendo le donne al centro della società dei servizi e spedendo a casa gli uomini che prima lavoravano in fabbrica. La struttura della famiglia cambia di conseguenza, e non è un caso che sull’aborto sia impossibile tornare indietro malgrado 30 anni di propaganda reazionaria. Siamo nel pieno di un enorme mutamento sociale che purtroppo non trova rappresentazione politica.
Torniamo suipunti di contatto. Uno è il riferimento all’«in-between» arendtiano, comune anche alla teoria politica femminista italiana che fa perno sulla categoria e sulla pratica della relazione. L’altro, connesso, io lo trovo nella tua insistenza sulle strategie discorsive e narrative che metti alla base della tua concezione della democrazia deliberativa. La nostra pratica del «partire da sé» può esser vista come una di queste strategie narrative.
Pare anche a me. A me sta a cuore enfatizzare la relazione come aspetto costitutivo dell’individuo e della collettività. E la narratività come aspetto costitutivo del sé, delle culture, dello scambio interculturale e del confronto pubblico. La narrazione smentisce la concezione identitaria e olistica delle culture come entità compatte e incomunicanti, spezza le opposizioni congelate fra islam e occidente, religione e laicità, pubblico e privato, eterosessualità e omosessualità e via dicendo. E’ cruciale nella costruzione di una sferapubblica non statuale, aperta ai movimenti della società civile, e di processi deliberativi che tengano davvero conto delle differenze e del modo in cui emergono, si contaminano, si interrogano a vicenda.
Qui forse c’è una differenza fra noi da evidenziare. Per il femminismo della differenza italiano le pratiche ridisegnano la sfera pubblica e fanno politica di per sé, tu invece vedi la discorsività in funzione di più ampi processi deliberativi e normativi e di una rivitalizzazione della democrazia.
Tutta la teoria femminista americana ha lavorato molto nell’ultimo decennio sulla democrazia, la sfera normativa, la teoria costituzionale. In effetti, stiamo facendo la nostra «lunga marcia attraverso le istituzioni».
Ma la democrazia come si presenta oggi merita tanta dedizione? Qual è lo stato della democrazia americana dal tuo punto di vista?
E’ uno stato preoccupante. L’11 settembre ha ridisegnato il profilo della sovranità in terminiestremamente contraddittori: a un evento sintomatico dell’era post-westfaliana, gli Usa hanno reagito con il linguaggio della sovranità statuale tradizionale. L’Impero è senza egemonia. All’interno, la «guerra al terrore» - una guerra mai dichiarata contro un nemico non identificato e non identificabile - viene usata come giustificazione per aumentare il potere dell’esecutivo. Il congresso ha dato al governo poteri di polizia; il Patriot Act è una legge tremenda, imprecisa, che apre una sorta di stato di guerra nello stato di pace. Ma ci sono anche dei cambiamenti di lungo periodo che cominciano prima e vanno oltre l’impatto dell’11 settembre.
Quali? Questa tua visita in Italia ti fa venire in mente dei paragoni fra le tendenze della democrazia americana e quelle della democrazia italiana?
Direi proprio di sì. Qui e là mi pare che agisca la stessa crisi della democrazia costituzionale e la stessa tendenza al cesarismo, al plebiscitarismo, allo svuotamento dellarappresentanza. E ancora, un’analoga trasformazione del rapporto fra politica ed economia, che privatizza l’amministrazione e fa fuori il concetto di pubblico. Con Bush negli Stati uniti è passata l’idea che il governo è una forma di business e che tutto si può appaltare ai privati, dalle prigioni alla gestione dei beni comuni. Con i risultati che abbiamo visto, a Abu Ghraib come a New Orleans, e con una emorragia continua del senso della responsabilità pubblica e, direi, dell’onore pubblico. Non è questione di destra e sinistra: in gioco c’è il destino della res publica.
La tendenza al cesarismo e al plebiscitarismo non va di pari passo con il crescere di quella «estetica dell’individualismo» che denunciavi prima? E questo, non dovrebbe riaprire una riflessione radicale sulla democrazia, sul rapporto fra individuo, massa e potere che ovunque in Occidente si sta riconfigurando?
Plebiscitarismo e individualismo vanno insieme anche per via della crisi delleistituzioni della società civile, dalla famiglia alla scuola. A questo bisogna aggiungere - negli Usa e, mi pare, anche in Italia - il risentimento delle nuove élite di governo contro le élite intellettuali storiche, e l’azione invasiva e pervasiva delle tv e dei media elettronici che «occupano» la sfera pubblica passivizzandola (e negli Usa spargono semi di fondamentalismo religioso). Anche se io sono convinta che le nostre società non siano totalitarie, e che due secoli di democrazia americana ci abbiano vaccinato dal totalitarismo, non posso fare a meno di ripensare alle analisi di Hannah Arendt sulla distruzione degli spazi di rappresentazione e articolazione del sé che fu all’origine del totalitarismo.da Il Manifesto
|