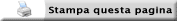|
Essere nella più intima e complessa delle essenze e sull’altro asse cartesiano Apparire, ovvero la nostra impronta letta e comparata da quella macchina prodigiosa che è la società, gli altri.
Tra le due istanze, la maschera, saldata strettamente sul volto, trappola e mezzo vile per preservarsi ma anche espediente per continuare ad esistere. Così un grande Gabriele Lavia legge e interpreta nel duplice ruolo di regista e protagonista, “Tutto per bene”, dramma di Luigi Pirandello, nato novella nel 1906 e trasferito sulla scena nel 1920 per le corde espressive del magnifico Ruggero Ruggeri. Si può vivere di dolore e nel dolore, lustrarsi l’aureola di martire del destino, si può ignorare a tal punto la realtà da non vedere il vermicolante mondo che ci circonda anche se è poi quello dei nostri intimi? E intorno si agitano vendette, equivoci, tradimenti, ipocrisie, emozioni nere, violente, opportunismi, sguardi carichi di irosa complicità e il disprezzodi chi ha costruito un proprio meccanismo stereotipato, una convinzione inossidabile che costringe il povero uomo nel baratro dell’emarginazione, mentre il dolore viene spinto al margine e la sua maschera è spezzata senza alcun riguardo. La scena iniziale di questo dramma fondamentale per la poetica e la filosofia di Pirandello, qui, al Teatro Argentina, ci racconta l’antefatto, un prologo indispensabile, che si svolge in casa Lori, con Silvia Ascensi, la moglie, distesa in quel letto che ha accolto i suoi ultimi istanti di vita, in un ambiente scuro e profondo, con il vedovo che le stringe convulsamente la mano quasi a regalarle quel tepore che la morte le ha sottratto definitivamente.
Ed è qui, che Martino Lori si ritrova a difendere con forza disperata quella spoglia dall’amico e protettore Salvo Manfroni, l’onorevole, che vorrebbe sottrarlo a quell’estremo abbraccio e gestire la fine lui, l’amante, ruolo di cui il marito ignora l’esistenza. Lei, Silvia, aveva costituito unabarriera fra Martino e gli altri, aveva costruito il rifugio privilegiato, il porto sicuro dove l’indifferenza, l’emarginazione degli amici, dei compagni di lavoro non faceva male. Ora Martino ha fatto innalzare per lei una tomba degna del suo dolore e del suo rimpianto, alla fine di un vialetto di ghiaia al cimitero, sotto la protezione di un enorme angelo che, in certo modo, ne esalta la memoria, anche per il più distratto dei frequentatori di quel luogo d’oblio.
Quando si alza il sipario sono passati sedici anni, Martino ha assolto il suo scopo diuturno, andare a raccontare alla poverina che non c’è più i fatti del quotidiano. Tappa d’obbligo di una vita squallida tutta nutrita di memorie, una vita che lo ha sottratto definitivamente ad ogni interesse, lo ha reso umile, sommesso, goffo, disperato, triste e sempre fuori luogo, anzi un ingombro, anzi un incompreso. Persino ora che un evento felice dovrebbe rinvigorirlo e assegnargli un ruolo di primo piano, perché Palma, l’amatafiglia, va sposa al giovane marchese Gualdi, squattrinato come molti nobili che lasciavano le ricche terre siciliane per sperperare fra i lussi di Montecarlo patrimoni creduti inestinguibili. Ma il grado sociale, il salto di qualità per Palma è ora assicurato. Ne gode intimamente Manfroni, che le sta accanto per farle compagnia trasmettendole forza e determinazione, visto che il padre non riesce a uscir fuori dagli intrichi che gli si stringono addosso, inesorabili come il dolore.
Ma il potente Manfroni, arrivista politicante (Gianni De Lellis), per Palma non è solo un amico fedele, che la sostiene, è quel padre segreto al quale riconosce ogni diritto, infastidita dalla presenza dell’altro padre, quello legale, che lei disprezza con tutte le fibre, che crede uno squallido opportunista che ha saputo chiudere gli occhi per non vedere la tresca fra Silvia e Manfroni e che ha accettato come sua la figlia nata da quell’amore proibito, per tornaconto, per viltà, compiacendosi dei favoriche l’onorevole non gli lesinava. Palma ormai, moglie e padrona di casa, perfettamente a bell’agio nel ruolo sociale, ha preso a detestarlo con forza e con crescente insofferenza.
Il finale è in linea con la poetica pirandelliana, quella stessa che gli suggerisce l’ambiente della sua Girgenti, dove il non detto è più dirompente del rivelato, ma dove tutto trova collocazione ideale quando si squarcia il velo di ipocrisie e di silenzi e il cuore e la verità diventano protagonisti. Il bellissimo spettacolo, creato da Lavia, che vede protagonista sua figlia Lucia nel ruolo di Palma, mostra “il dramma rappresentato quando esso è già da gran tempo finito” e si articola in due tempi, ambedue determinati e caratterizzati dalla presenza scura e ingombrante della tomba di Silvia, che il regista ha voluto fissa come un diaframma in penombra fra la platea e il palcoscenico.
La regia di Lavia sottolinea, in armonia con lo stesso autore, affascinato dalla nuova arte del cinematografo,l’aspetto thriller, anzi il mistery per il senso del dramma incombente e luttuoso con lo spettatore che sospetta che qualcosa di grave sia intercorso fra i personaggi, ma attende che lo svolgimento finale gli mostri la verità. E la verità è un uomo che ha perduto lo schermo che gli impediva di cogliere gli eventi nella loro essenza ma che nel contempo gli dava una statura che con la conoscenza dei fatti è costretto a perdere per ritrovarsi in una solitudine aberrante senza un passato da rimpiangere, senza un presente, perché in realtà nessuno lo accetta, e senza un futuro possibile ora che il sospetto del tradimento della moglie idolatrata gli ha strappato ogni protezione. L’allestimento, “personaggio” aggiunto dovuto all’estro di Alessandro Camera, obbedisce ai canoni di uno spettacolo per certi versi straniante e deformato, come quel divano iperbolico del secondo atto, come quei finestroni che s’aprono nella ricca casa di Palma, che fanno pensare al Liberty adottato come una secondapelle nelle belle case siciliane.
L’effetto di straniamento è anche in quel modo particolare che Lavia regista ha imposto ai suoi attori che d’improvviso, mentre la musica, scelta con cura meticolosa da Giordano Corafi, diventa protagonista, si fermano e si muovono all’indietro, al ralenty, come volessero ripercorrere i loro passi ed attestarsi nelle vecchie posizioni. Lo spettacolo è tutto all’insegna dell’eleganza, le attrici indossano vestiti magnifici e pellicce e gioielli, simbolo di un benessere che va persino al di là del mondo borghese dal quale provengono, dovuti alla fantasia di Andrea Viotti. Sul palcoscenico anche Riccardo Bocci, Giorgio Crisofi, Riccardo Monitelli, Woody Neri; Daniela Poggi, Dayana Roncione, rigorosamente in ordine alfabetico come si conviene ad un cast così affiatato.Franzina Ancona
|